
Jacob Levi Moreno
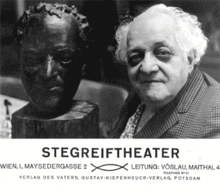
Jacob Levi Moreno, nato Jacob Moreno Levy (Bucarest, 18 maggio 1889 – Beacon, 14 maggio 1974) è stato uno psichiatra rumeno, naturalizzato austriaco e statunitense.
Moreno è conosciuto soprattutto come padre dello psicodramma, del sociodramma e dei metodi attivi, ed è considerato il protagonista della terza rivoluzione psichiatrica, dopo quelle di Alfred Binet e di Sigmund Freud, in quanto ha sviluppato un modello interpersonale della personalità, contrapposto al modello intrapersonale di Freud.
Molte delle tecniche e strategie di lavoro nei gruppi ideate da Moreno (dal role playing alla ristrutturazione psicodrammatica di sogni e avvenimenti alla sociometria) sono stati acquisti da diversi approcci e scuole di psicoterapia successive, tra cui la psicoterapia della Gestalt, la psicoterapia sistemico-familiare e le costellazioni familiari.
Indice
Biografia
Infanzia

Jacob Moreno Levy nacque a Bucarest da Moreno Nissim Levy e Paulina Iancu, maggiore di cinque fratelli. Il padre apparteneva a una famiglia di commercianti ebrei sefarditi, provenienti originariamente dalla Turchia ed emigrati dapprima in Bulgaria, a Pleven, e infine in Romania. La sua infanzia fu caratterizzata da una situazione familiare difficile, dovuta alla lontananza del padre e all'inadeguatezza della madre, ma pure da un amore per il gioco, il canto e la conoscenza di varie lingue, tra le quali il giudeo-spagnolo.
A Vienna
Si trasferì con la famiglia a Vienna nel 1905, dove studiò medicina, matematica e filosofia; nel 1912 assistette a una lezione di Freud, al quale, secondo un aneddoto riportato nella sua autobiografia, disseː
|
«Ebbene, dottor Freud, io comincio dove lei finisce. Lei incontra le persone nel setting artificiale del suo ufficio. Io le incontro nelle strade e nelle loro case, nel loro ambiente. Lei analizza i loro sogni. Io do loro il coraggio di sognare ancora. Lei le analizza e le scompone. Io consento loro di agire i loro ruoli conflittuali e le aiuto a comporre le parti separate» |

Tra il 1914 e il 1915 pubblicò tre piccoli libri dal titolo "Invito a un incontro" con le sue idee di base: l'importanza del creatore rispetto alla sua creazione, il concetto di inversione di ruolo (che diventerà una tecnica fondamentale dello psicodramma) e la nozione di incontro, inteso come esperienza interpersonale profonda.
Laureato in medicina nel 1917, all'università di Vienna, iniziò ad esercitare la professione negli anni della prima guerra mondiale, lavorando prima in un campo di rifugiati in Austria, Mittendorf, dove erano evacuate molte famiglie italiane del Trentino, e successivamente a Znolnok, in Ungheria. Qui iniziò a indagare le potenzialità della sociometria, intesa come lo studio delle relazioni che legano i componenti dei gruppi e i vari gruppi tra loro.
Nel primo dopoguerra, riprese la sua attività di medico e di ricercatore e frequentò alcuni celebri luoghi di ritrovo (cafés de Vienne) dove fondò la rivista Daimon (1918-1922) assieme a importanti collaboratori, quali Alfred Adler, con il quale conserverà una lunga amicizia, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Martin Buber, e Max Brod. Il titolo della rivista fa riferimento alla parola greca "Demone" o Genio che indica sia lo spirito buono che quello cattivo che convivono nell'essere umano. Su Daimon, Moreno introdusse lo psicodramma con tre dialoghi considerati protocolli assiodrammatici cioè con un fondamento etico-morale più che clinico scientifico.
Nel 1918 Moreno divenne ufficiale sanitario a Bad Vöslau, a 40 chilometri a sud di Vienna. Qui abitò in una casa all'indirizzo di Maital 4 a cui rimase sempre affettivamente legato e che è ora monumento protetto in sua memoria. Gestì l'incarico di medico di fabbrica, lavoro che gli rendeva abbastanza da permettergli di prestare i suoi servizi gratuitamente agli abitanti del paese. Durante questo periodo, conobbe Marianne Lornitzo, sua segretaria, amante e musa. Nel 1919 pubblica il nuovo Daimon col titolo "Die Gefahrten" (i Compagni) ospitando lavori di Franz Blei, Ernest Bloch (compositore e filosofo della musica), Paul Claudel e Martin Buber. Nel 1920 Moreno scrisse "Le parole del padre", un testo poetico, spirituale e onirico, centrato sull'archetipo del Padre, della Creazione e della Divinità.
A Vienna Moreno fondò il teatro della spontaneità. La sera del 1 aprile 1921 ebbe luogo la prima dimostrazione di quello che in seguito venne chiamato sociodramma: Moreno lasciò una poltrona vuota sul palcoscenico del Komodienhaus invitando i presenti a sedervisi e ad agire il ruolo del Re.
In seguito a questo esperimento drammaturgico, Moreno ideò un bizzarro Teatro a pianta centrale con palchetti a corolla e lo presentò a Vienna all'Esposizione Internazionale delle Nuove Tecniche di Teatro organizzata dall'architetto Fredrich Kiesler nel 1924. Poiché anche Kiesler presentò all'Esposizione un suo teatro circolare realizzato in legno e a grandezza naturale, Moreno lo accusò di avergli copiato l'idea. Il conflitto tra l'architetto e il medico-filosofo-regista fu così acceso che finì in tribunale. Secondo Zerka Toeman Moreno, nel teatro di Kiesler uno spettatore si muoveva su uno scivolo che permetteva di cambiare il suo punto di vista, un po’ come sul Carosello del Prater. Una caricatura uscita sui giornali mostra un match di boxe tra gli autori dei due progetti, in cima al teatro di Kiesler, animato da un forte dinamismo, un po' surreale, un po' espressionista.
La vita in America e il Beacon Institute
Il primo approdo in America è nell'ottobre del 1925 a New York dove brevettò una macchina di registrazione del suono prodotta con la General Phonograph Corporation. Nel 1926 Moreno emigrò negli Stati Uniti dove creò le basi professionali dello psicodramma. Nel 1930 sviluppò la ricerca delle interazioni sociali all'interno dei gruppi; introdusse le sue scoperte nel 1931 in un Convegno dell'Associazione Americana di Psichiatria a Toronto. Grazie a French Morse, curatrice di una scuola di formazione, presentò in varie università la sociometria e la psicologia di gruppo nel 1932 e infine la teoria dei ruoli nel 1934. Nel 1931 svolge una ricerca presso il carcere di Sing-Sing applicando per la prima volta la psicoterapia di gruppo in un istituto di detenzione, Successivamente, nel 1934, divenne direttore di ricerca dell'Istituto correzionale femminile di Hudson.
Moreno conquista il consenso della psichiatria, delle università e delle istituzioni. Le intuizioni filosofiche e profetiche del periodo viennese si articolano in tecniche di intervento concrete e misurabili. Dall’America il metodo si diffonde progressivamente nel resto del mondo, fino alla Cina, all’India, al Giappone. Nel 1932 Moreno mette a punto il concetto di «psicoterapia di gruppo» – in relazione a un progetto di psicoterapia nelle carceri di Sing-Sing – e lo presenta al congresso dell’Associazione Americana di Psichiatria. In collaborazione con H. Jennings, studia una comunità di ragazze in un istituto di detenzione, dal punto di vista sociometrico, cioè misurando le tensioni affettive e i livelli di vicinanza, distanza e reciprocità tra i membri del gruppo. A partire da questi esperimenti, psicodramma e role playing si rivelano efficaci, sia nel mondo reale - per la formazione, la prevenzione, la scuola, le comunità, gli eventi culturali - che nell’analisi di gruppo e nella psicoterapia. Nel 1936, Moreno crea in una cittadina vicino a New York il Beacon Institute, una clinica psichiatrica dove apre anche casa editrice Beacon House. Da Beacon, sede di viaggi di studio e formazione di medici, sociologi, psichiatri e ricercatori, lo psicodramma si diffonde in tutto il mondo. Nel 1937 Moreno costruisce il Teatro terapeutico di Beacon grazie al sostegno finanziario di Gertrude Tone, madre di Franchot Tone, un famoso attore dell'epoca.
Nel 1941 incontra Zerka Toeman, che divenne sua moglie, collaboratrice e dirigente della clinica e dell'istituto di sociometria. Dal matrimonio nasce Jonathan alla cui educazione concorsero momenti di gioco psicodrammatico. Nel 1942 Moreno fonda l'ASGPP (American Society of Group Psychoterapy and Psychodrama). Nel secondo dopoguerra Moreno fa molti viaggi di lavoro tra l'America e l'Europa e partecipò a congressi in Francia e Gran Bretagna. La sua influenza esce dal mondo della psicologia e, come racconta Zerka Moreno all'americanista Fernanda Pivano, si estende alla controcultura americana, al Living Theatre e all'Actors Studio. I primi film di Hollywood in cui compaiono scene ispirate alle tecniche di Moreno sono Io ti salverò e Marnie di Alfred Hitchcock.
Moreno muore il 14 maggio 1974, a Beacon, in seguito a una crisi cardiaca, e viene sepolto a Vienna, secondo i suoi desideri, con questa iscrizione:
Fondatore della Sociometria, della Psicoterapia di gruppo, dello Psicodramma: L’uomo che portò la gioia e il sorriso nella psichiatria.
Zerka Toeman Moreno, dopo aver ceduto il Teatro e l'Istituto di Beacon alla Horsham Foundatiom, ha continuato a dirigere seminari in tutto il mondo.
Tra gli studenti più rappresentativi della prima generazione: Anne Ancelin Schutzenberger, Gretel Leutz, Marcia Karp, Lewis Yablonsky.
Innovazioni
Le sue teorie e i suoi metodi, affidati a libri tradotti in più di 20 lingue, introducono una nuova forma di ricerca attiva (action methods) basata sull'azione e il corpo che nel setting psicoanalitico classico sono banditi. Autore di un nuovo approccio sistemico della psichiatria sociale ("sociatria") e della "microsociologia" l'osservazione microscopica dei fenomeni associativi, Moreno analizzò piccoli gruppi, parzialmente isolati dal contesto sociale e propose che il gruppo costituisce l'atomo funzionale delle dinamiche sociali, un nucleo che, combinandosi con altri gruppi, dà vita a strutture sempre più complesse. Il pensiero psico-sociale di Moreno ruota intorno ai concetti di ruolo, relazione interpersonale, creazione, creatività e spontaneità. Le sue tecniche di gioco di ruolo psicodrammatico hanno una valenza clinico-terapeutica, ma vengono applicate anche nella Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, nella Formazione professionale, nelle Comunità Terapeutiche e nelle Scuole di Teatro per attori.
Per Moreno la Catarsi non ha il significato che le danno Aristotele o Freud rispetto al suo effetto sul pubblico ma consiste nell’azione di chiunque metta in scena la sua vita come attore-autore del suo destino. La Psico-Catarsi è correlata alla Spontaneità e alla creatività esistenziale. Non si limita all'abreazione di traumi e sentimenti repressi ma realizza nuovi giochi di ruolo che liberano il paziente dal suo disagio e dai suoi traumi. Il protagonista del gioco, con l’aiuto del gruppo, esprime e vede i ruoli che lo imprigiona e impara a costruire un contesto più libero. Il modello di Moreno è stato spesso accostato all'immaginazione attiva di Jung e all'opera di Luigi Pirandello di cui rappresenta una versione terapeutica: la catarsi inizia nel momento in cui il paziente (anziché scriverli) rappresenta i suoi personaggi in cerca d’autore e li elabora come regista e autore.
Lo psicodramma analitico
Nel dopoguerra, in seguito a missioni di studio di medici e psichiatri dell'infanzia francesi, al suo Beacon Institute (New York), la stessa psicoanalisi, che inizialmente aveva preso le distanze da Moreno, ha progressivamente integrato le sue innovazioni. Tra i pionieri dello psicodramma analitico Serge Lebovici con R. Diatkine, E. Kestemberg, J. Favez Boutonier, Anne Schützenberger del Gruppo Francese di Sociometria, Simone Blajan-Marcus e i lacaniani Gennie e Paul Lemoine fondatori della SEPT di Parigi attiva anche in Italia. Daniel Widlocher, formato alla tecnica con Paul Gravel e G. Testemale Monod, applica l'invenzione di Moreno ai bambini, come l'analista Didier Anzieu autore di un importante libro Lo psicodramma analitico del bambino e dell’adolescente. Queste applicazioni analitiche riducono, in varia misura, la carica di Spontaneità del gioco e danno importanza all'emersione del transfert gruppale anziché allo sviluppo di quella empatia reciproca che Moreno definisce tele.
Dopo la morte di Moreno nel 1974, lo psicodramma dà una vitalità gruppale a varie correnti psicoanalitiche soprattutto a quella di Jung che accorda grande importanza all'immaginazione attiva.
Influenza su altre correnti di psicoterapia
I metodi di Moreno sono stati integrati o plagiati da varie scuole di psicoterapia. La corrente che maggiormente ha utilizzato le sue tecniche è la Psicoterapia della Gestalt di Fritz Perls a partire dal comune riferimento al concetto di "io e tu" di Martin Buber che fu uno dei primi collaboratori del giovane Moreno per la rivista viennese Daimon. Di derivazione psicodrammatica sono soprattutto alcune tecniche che Moreno iniziò a praticare a Vienna fin dagli anni '20 del '900 e che negli Stati Uniti Perls applicò e diffuse a Big Sur negli anni '50.. Tra queste: la messa in scena dei conflitti attraverso l'attribuzione di stati d'animo e idee a oggetti e membri del gruppo, la catarsi fisica di fronte a una sedia vuota, le tecniche di doppio e doppiaggio e il lavoro sul corpo grazie all'incontro con i membri del gruppo.
Nell'ambito della Psicoterapia sistemico-relazionale entrano tecniche attive come la descrizione dei conflitti e del sistema attraverso una rappresentazione plastica del gruppo familiare. Queste "sculture fenomenologiche" hanno una funzione di test e anche di comunicazione pubblica dei rapporti affettivi. È evidente la loro derivazione dalla messa in scena di un sociodramma familiare. Rientra in questa categoria la scultura familiare di Virginia Satir.
Il caso più problematico è la distorsione di alcune tecniche di psicodramma operata dalle costellazioni familiari di Bert Hellinger che hanno spesso portato a una diffusione selvaggia della influenza trans-generazionale e a danni emotivi dei partecipanti. Quella che Hellinger definisce rappresentazione istintuale di membri del gruppo finisce per essere una manipolazione. Per Moreno il gioco dei ruoli non è una dimensione istintiva e tanto meno medianica ma una semplice tecnica di messa in scena a soggetto con cui i membri del gruppo, scelti dal protagonista come interpreti, rappresentano i personaggi di una scena. Secondo la visione autoreferenziale e iperdirettiva di Hellinger, lo stato d'animo di chi incarna la costellazione rivelerebbe le verità nascoste del sistema familiare. A questo proposito è paradigmatica la risposta dello psicoanalista Didier Anzieu a René Diatkine, che nel 1954 aveva sostenuto come lo psicodramma mirasse alla valorizzazione dell'immaginario. Anzieu obiettò che Moreno aveva inventato gli interventi degli Ego ausiliari nello psicodramma proprio per evitare che il paziente si installasse, con la complicità di un conduttore seducente, in una soddisfazione narcisistica e megalomanica dove l'universo si piega ai desideri.
C'è poi da menzionare la similarità tra lo psicodramma a due e l'analisi attiva di Sándor Ferenczi, l'allievo eretico di Freud, che, seguendo suoi percorsi originali, utilizza il gioco di ruolo in analisi. Momenti psicodrammatici in senso lato sono pure presenti in alcuni casi clinici di Françoise Dolto e di Milton Erickson a riprova del generale superamento dal setting dialogica di cui Moreno fu il profeta dagli anni Venti del Novecento.
Psicocinema
Moreno con la sua teoria delle reti non ha inventato Internet ma per certi versi l'ha profetizzata. Nel 1946 auspicò l'avvento di uno Psico-cinema che, nelle articolazioni video e televisiva dello psicodramma e del sociodramma, avrebbe trovato uno spazio di libertà e rinnovamento esistenziale assolutamente nuovo. La condivisione e l'incontro si sarebbero allargati dal gruppo terapeutico vero e proprio a un numero infinito di spettatori distanti nel tempo e nello spazio. In questa ottica realizzerà con la RTF Radio televisione Francese, "Le Psychodrame" (1956, regia di Roberto Rossellini) con Godard come operatore e "Psychodrame d'un mariage" (1965, regia di Jean-Luc Léridon). I due esperimenti però non furono mai trasmessi dalla rete e il filmato di Rossellini rimase introvabile per anni finché Marco Greco (direttore del Moreno Museum) e Maria Cristina Sidoni non lo rinvenne nel 2018 negli archivi di Anne Ancelin Schützenberger e non ne organizzò nel 2019 il restauro per il video libro dell'Istituto Luce Cinecittà.
L'utopia moreniana dello Psico-cinema viene realizzata in Italia nel 1991 da Rai3 (diretta da Angelo Guglielmi) e dal Teatro Stabile di Torino (diretto da Luca Ronconi) con due serie del programma "Da Storia Nasce Storia" ideato e condotto da Ottavio Rosati, che ricava una puntata pilota dal laboratorio Giocare il sogno, Filmare il gioco (1990) con gli attori Alessandro Haber, Milena Vukotic e Rosalia Maggio come Ego ausiliari. Il format Rai, derivato dallo psicocinema di Moreno, consiste di veri psicodrammi senza soggetto e senza montaggio (con la regia televisiva di Claudio Bondì, allievo di Roberto Rossellini). La conduzione dà enfasi alla catarsi dei giochi e alla loro dimensione visiva. Va in onda in prima serata con quella risposta del pubblico che Moreno aveva profetizzato negli anni Cinquanta. La Stampa lo definisce il successo teatral-televisivo di fine anno.
Vittorio Gassman dedica allo psicodramma di Moreno una puntata del programma di Rai1 Tutto il mondo è teatro. Sempre la Rai ha prodotto il documentario di radio3 Il piacere dell’acting out di Ottavio Rosati, con la partecipazione di Dario Fo nel ruolo di J. L. Moreno.
Bibliografia
- Jacob Levi Moreno, Who Shall Survive? - Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo e sociodramma (1953), trad. it. Di Renzo, Roma, 2001.
- Jacob Levi Moreno, Manuale di psicodramma 1: il teatro come terapia, a cura di Ottavio Rosati, Astrolabio, Roma, 1985 (Beacon House Inc., 1946).
- Jacob Levi Moreno, Zerka Toeman Moreno, Manuale di psicodramma 2: Tecniche di regia psicodrammatica, a cura di Ottavio Rosati, Astrolabio, Roma, 1987 (Beacon House Inc., 1969)
- Jacob Levi Moreno, Il teatro della spontaneità (1947), trad, it. a cura di Antonio Santoni Rugiu con una nota di Giuseppe Bartolucci, Guaraldi, Firenze, 1990.
- Jacob Levi Moreno, Zerka Toeman Moreno, Gli spazi dello psicodramma, a cura di Ottavio Rosati, Di Renzo, Roma, 1995 (Beacon House Inc., 1959)
- Jacob Levi Moreno, Un matrimonio da fare, a cura di Ottavio Rosati, Di Renzo, Roma, 2005.
- Jacob Levi Moreno, Psicomusica, a cura di Ottavio Rosati, Di Renzo, Roma, 2006.
- Jacob Levi Moreno, Il profeta dello psicodramma, a cura di Ottavio Rosati, Di Renzo, 2007.
- Jacob Levi Moreno, Le Parole del Padre (Das Testament des Vaters, Vienna, 1923), a cura di Joe Quercia, Phasar, Firenze, 2014.
- Jacob Levi Moreno, Autobiography of a Genius (Preludes to my autobiography, Beacon House inc., 1989) edited by Edwrd Schreber, Sara Kelley and Scott Giacomucci, North West Psychodrama Association, 2019.
Bibliografia su Jacob Levi Moreno
- Pierre Bour, Psicodramma e vita, Rizzoli, 1973.
- Lewis Yablonsky, Psicodramma - Principi e Tecniche, Ubaldini, Roma, 1978.
- Ottavio Rosati, Pirandello e lo psicodramma in Italia, 1982, rivista Atti dello Psicodramma, Ubaldini, Roma, 1982.
- Ottavio Rosati, Jacob Levi Moreno e il piacere dell'acting out, 1985, radio documentario di Rai Radio tre con Dario Fo
- Ottavio Rosati, Questa sera si recita a soggetto, rivista Atti dello Psicodramma, Ubaldini, Roma, 1983.
- Gretel Leutz, Rappresentare la vita, Borla, Roma, 1987.
- Ottavio Rosati, La Moreno per Pirandello e Ciascuno a suo modo, rivista Atti dello Psicodramma, Ubaldini, Roma, 1987.
- René Marineau, Jacob Levy Moreno 1889-1974, Tavistock & Routledge, London and New York, 1989.
- Paola De Leonardis, Lo scarto del cavallo. Lo psicodramma come intervento sui piccoli gruppi, Angeli, Milano, 1994.
- Ottavio Rosati, Da Storia Nasce Storia, prefazione di Fernanda Pivano, Nuova Eri-Rai,1994.
- Giovanni Boria, Psicoterapia psicodrammatica, Franco Angeli, 2005.
- Anne Ancelin Schutzenberger, Lo Psicodramma, Di Renzo, Roma, 2008 (ed. or. Le Psychodrame, Payot e Rivage, Paris, 2003)
- Zerka Toeman Moreno, "Per sognare ancora", a cura di Joe Quercia, ed. Phasar, 2017 (ed or. To Dream Again: a memoir, Mental Health Resources, 2012)
- Salvatore Veca, Moreno, psicodramma e sociometria, Aut Aut, marzo 1967, Lampugnani Nigri, p.95.
Filmografia su e di Jacob Levi Moreno
- Jean-Luc Leridon, Psychodrame d'un marriage, Radiodiffusion-Télévision Française, 1965.
- Roberto Rossellini, Psychodrame (RTF - 1956), Istituto Luce Cinecittà, 2019.
Voci correlate
- Anne Ancelin Schützenberger
- Catarsi
- Da Storia nasce Storia
- Psicodramma
- Sociometria
- Sociogramma di Moreno
- Teatro della spontaneità
- Zerka Toeman Moreno
Altri progetti
Altri progetti
-
 Wikiquote contiene citazioni di o su Jacob Levi Moreno
Wikiquote contiene citazioni di o su Jacob Levi Moreno
-
 Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jacob Levi Moreno
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jacob Levi Moreno
Collegamenti esterni
- Moreno, Jakob Levy, su sapere.it, De Agostini.
- (EN) Jacob Levi Moreno, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Opere di Jacob Levi Moreno, su Open Library, Internet Archive.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 86620130 · ISNI (EN) 0000 0001 1450 9463 · SBN SBLV084845 · LCCN (EN) n50005657 · GND (DE) 118584014 · BNE (ES) XX1039683 (data) · BNF (FR) cb120153925 (data) · J9U (EN, HE) 987007265527405171 · NDL (EN, JA) 00621161 · CONOR.SI (SL) 35383907 · WorldCat Identities (EN) lccn-n50005657 |
|---|